Parlare dell’eredità filosofica di Gioacchino da Fiore significa, secondo noi senza alcun residuo, parlare tout court della portata filosofica della rivelazione cristiana. È una tesi radicale, come si capisce, che però proprio nella situazione attuale della filosofia sembra potersi affermare senza scandalo.
A parte ovviamente il pensiero filosofico cristiano più legato alla tradizione della metafisica aristotelico-tomista, l’idea della svolta impressa dal cristianesimo alla filosofia era stata formulata in modo emblematico e in qualche senso esemplare per la cultura di tutto il Novecento, da Wilhelm Dilthey, nella sua (incompiuta) Introduzione alle scienze dello spirito, del 1883.
Dilthey, che raccoglieva ma anche in qualche modo “urbanizzava” l’eredità di Hegel nello spirito della ripresa tardo ottocentesca del kantismo, individuava il senso della svolta impressa alla filosofia dal cristianesimo nell’aver spostato lo sguardo dal mondo esterno, almeno esterno al soggetto, come era il mondo delle idee di Platone, all’interiorità: in interiore homine habitat veritas, il motto agostiniano era, per Dilthey, l’inizio del cammino che avrebbe condotto la filosofia al soggettivismo trascendentale di Kant: l’uomo interiore è in quest’ultimo la ragion pura portatrice delle forme a priori entro le quali soltanto l’esperienza sensibile si costituisce in esperienza di un mondo, in scienza e anche in moralità.
Da Gesù, e da Agostino, a Kant, avevano dovuto passare tuttavia molti secoli, a causa del fatto che la Chiesa cristiana (e ancora, di ciò, la persona di Agostino è l’emblema) non aveva solo da curare il messaggio di Gesù ma aveva dovuto anche farsi carico delle strutture del mondo temporale, ridotte in rovina dalla caduta dell’impero romano.
Agostino non era solo un filosofo, ma anche un vescovo; e così la Chiesa, per molti secoli, aveva dovuto non solo insegnare la rivelazione all’uomo interiore, ma anche reggere in molteplici modi le strutture esteriori della comunità.
Con questa responsabilità la Chiesa si era trovata ad ereditare anche la cultura del mondo antico, e con essa tutto quello “oggettivismo” che la dominava, il mondo delle idee eterne, l’ordine razionale del mondo, le essenze, insomma il “realismo” che avrebbe permeato la filosofia e la teologia cristiane per tanti secoli. Fino, appunto, a Kant, che aveva finalmente inaugurato quella che a Dilthey appariva essere la “metafisica dei moderni”, che realizzava anche in modo (quasi) completo l’effetto del cristianesimo.
Questo schema diltheyano, tanto più pervasivo e convincente quanto più non era una semplice invenzione di Dilthey, ma già eredità di Hegel e prima dell’illuminismo e di Descartes, si ritrova in tanti pensatori successivi che lo riprendono da lui, come Heidegger, o che lo condividono negli stessi anni senza mutuarlo esplicitamente da lui, come Nietzsche.
Richiamarsi a Gioacchino come a colui che realizza nel modo più radicale il senso del cristianesimo per la filosofia significa inserirsi in questa tradizione “diltheyana” e tuttavia superarla, in una direzione ontologica che è facilmente ricollegabile proprio - con una certa violenza ermeneutica - a Nietzsche, e senza alcun arbitrio a Heidegger.
Non è senza significato, secondo noi, che, se non Gioacchino stesso certo la sua “posterità” anche prossima, come quella degli spirituali discepoli di Fra Dolcino, abbia più o meno esplicitamente ricondotto l’incapacità della Chiesa di realizzare tutta la portata, anche filosofica, del cristianesimo al suo coinvolgimento con i poteri di questa terra. La situazione in cui, secondo noi, si può sostenere finalmente la tesi qui proposta, e cioè che Gioacchno sia colui che, per noi oggi, realizza nel modo più pieno il senso del cristianesimo per la filosofia, è quella che possiamo descrivere richiamando i nomi di Dilthey, di Nietzsche, di Heidegger.
Traduciamo: c’è un nocciolo “cristiano” che ha lavorato nella filosofia moderna fin da Sant'Agostino, e che non ha potuto farsi valere per molti secoli a causa della “compromissione” della Chiesa con il potere terreno. A un certo punto (per Dilthey certo anche in virtù della Riforma luterana, dell’Illuminismo, di Hegel) il nocciolo cristiano è riuscito a emergere, e ha dato luogo alla dottrina di Kant.

Ma ben oltre Dilthey, e comunque sulla base da lui preparata, si colloca una lettura ancora più radicale della eredità cristiano-gioachimita nella filosofia, quella di Heidegger (che a sua volta interpreta in senso ontologico e post-metafisico il nichilismo di Nietzsche). Non si tratta più solo dell’homo interior di Agostino; ma dell’essere stesso che, anche in nome della verità dell’homo interior (l’esistenza come progetto gettato che ispira la polemica di Heidegger contro la metafisica “oggettivistica”), si svela finalmente come EVENTO, come accadimento, e non come struttura data una volta per tutte.
Gioacchino è del resto un “esperto” di violenza ermeneutica, dunque non sarà in un ambiente come questo, o da parte di suoi cultori, che si potrà rimproverare a questa tesi interpretativa una qualche infondatezza. Ci sono sicuramente molte difficoltà, a cominciare dalla lettera dei testi: di Gioacchino stesso, di Heidegger, eccetera. A cominciare dal fatto che Heidegger parla dell’essere ma non di Dio; e certo, almeno a partire da un determinato momento della sua carriera di filosofo, ha assunto posizioni acristiane se non esplicitamente anticristiane.
Ci si perdonerà dunque, sia in spirito “gioachimita”, sia nello spirito di quella “caritas” che deve ispirare ogni buona ermeneutica, di procedere per generalizzazione alquanto vaste, ma non per questo meno seriamente sostenibili.
Dunque, il punto di partenza dell’accostamento che sta alla base della tesi è il senso fondamentale della polemica di Heidegger (e non solo di lui) contro la metafisica come pensiero che identifica l’essere con l’ente.
Heidegger come si sa inaugura questa polemica con Essere e tempo nel 1927; echeggiando in quell’opera una vasta area di pensiero continentale, che è anche il terreno dell’esistenzialismo.
Il perché dell’insoddisfazione “esistenzialistica” di Heidegger verso il concetto di essere ereditato dalla metafisica è che esso, con la sua insistenza sulla stabilità, oggettività, in definitiva sulla eternità di ciò che davvero è, renderebbe impossibile pensare come essere proprio l’esistenza di quell’ente che predica l’essere degli enti e pone la domanda sul suo senso. Questa domanda si ripropone a Heidegger non perché prima sia stata dimenticata colpevolmente o per una qualche distrazione dei filosofi. La domanda, appunto, Si ripropone perché accade qualcosa nel mondo. Il fatto è che la metafisica oggettivistica è giunta a un tale estremo di riduzione dell’essere agli enti, che l’esistenza umana - libertà, memoria, progetto - non solo non si riesce a pensare come essere; ma è minacciata da una razionalizzazione generale della vita sociale che riduce l’uomo a ingranaggio di una grande macchina produttiva, quella che poi verrà rappresentata, pochi anni dopo Essere e tempo, in film come Tempi moderni di Chaplin.
È importante sottolineare, e tenere presente continuamente, questa ispirazione “esistenzialistica” di Heidegger, non solo perché altrimenti la sua impresa di riproporre il problema del senso dell’essere apparirebbe solo come un ennesimo tentativo “metafisico” di descrivere adeguatamente qualcosa che da sempre è davanti agli occhi e che non si è ancora riusciti a vedere - dunque proprio nel senso più oggettivistico della metafisica. Ma anche perché proprio questo, anzitutto, lo avvicina a Gioacchino, prima ancora che (o insieme a, esattamente come) la nozione di essere come evento.
Chi non pensa di essere qualcuno che finalmente può svelare al mondo le cose “come stanno”, più veridicamente che quei poveretti di Platone, Aristotele, Kant, Hegel, ecc. - come fatalmente deve pensare un pensatore dell’oggettività - non può che cercare di ascoltare l’evento dell’essere; e viceversa, di modo che i due aspetti - concepire l’essere come evento, e cercare di cogliere i segni dei tempi - sono del tutto identici.
Gli interpreti di Gioacchino- non posso dire: tutti, e cioè quelli censiti e esposti da De Lubac nella sua opera monumentale; ma diciamo un buon numero di quelli recenti, da Mottu a Andrea Tagliapietra nella sua lucida introduzione alla traduzione dell’Enchiridion super Apocalypsim - concordano sul fatto che la sua filosofia non si distingue dalla sua visione della storia, delle aetates, dei tre status suddivisi ulteriormente secondo la complessa aritmetica simbolica che i presenti conoscono assai meglio di me. Ebbene, i lettori di Heidegger (uno scrittore anche lui difficile, ma elementare in confronto a Gioacchino) sanno che, dopo Essere e tempo, egli si è dedicato quasi esclusivamente a una lettura dei segni del tempo.
Ho proposto di nominare, e possibilmente continuare, questa lettura con il termine (mutuato dall’ultimo Foucault) di “ontologia dell’attualità”.
Nello Heidegger maturo non c’è più nulla che faccia pensare a una descrizione filosofica di strutture stabili: l’uomo, il mondo, la cosalità delle cose, l’arte, eccetera. Il mondo prende nei suoi testi l’articolo indeterminativo (è sempre “un mondo”, come quello che è aperto, di volta in volta, dall’opera d’arte o dall’accadere, in altre forme, della verità); e la stessa umanità è pensata al plurale, sono LE umanità storiche quelle con cui abbiamo da fare. Il pensiero che si sforza di “pensare” l’essere è sempre tentativo di ascoltare il suo annuncio nel linguaggio storico e “destinale” (sono noti i “giochi” che Heidegger fa con le parole Geschichte e Geschick...) dell’epoca.
Nello scritto sul “Detto di Anassimandro”, contenuto in Holzwege (1950), Heidegger parla esplicitamente di una “epocalità dell’essere”; non credo che si possa identificare l’epoca di Heidegger con l’aetas, o lo status, di Gioacchino. Ma, almeno mi pare, non sono tanto lontani.
Tutto ciò perché l’essere non “è”, ma “accade”; e la stabilità e “oggettività” degli enti (quella a cui guarda la scienza, ma anche la vita quotidiana) si dà solo nella apertura di un’epoca e secondo i modi che le sono propri, e che accadono nel linguaggio che “ci” parla - parla a noi e parla a noi, il quale è sempre storicamente determinato.
Il senso del discorso che cerco di dipanare qui non è, devo appena ricordarlo, quello di offrire proposte interpretative su Gioacchino, i cui testi conosco molto approssimativamente; ma di sottoporre a studiosi dell’abate di San Giovanni in Fiore una ipotesi sulla sua possibile attualità, al fine di verificarne la plausibilità dal punto di vista di quei testi di cui sono un cultore marginale, se non superficiale. A questa excusatio aggiungo soltanto che i fedeli e competenti lettori di Gioacchino a cui sto parlando non dovrebbero oppormi eccessive obiezioni “filologiche”, come se si trattasse di accertare, con metodo di oggettività scientifica, che cosa Gioacchino abbia “davvero” detto o scritto. Come Heidegger si lascia riproporre il problema dell’essere dall’epoca in cui vive, così io, si licet, mi lascio appellare da Gioacchino a partire da ciò che sento risuonare nella mia “epoca” e vi leggo ciò che l’epoca (se si vuole un termine meno filosoficamente sospetto, l’esperienza) mi suggerisce di cercarvi.
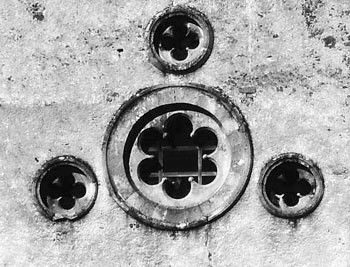
Questa suggestione epocale comincia dunque dal rilievo che oggi la filosofia - quella che ritengo degna del nome, ma che non si identifica tutta con Heidegger - si sforza di pensare l’essere come evento piuttosto che come struttura stabile, oggettiva. E in fondo per le stesse ragioni che muovevano Heidegger nel 1927.
E’ dunque lo “storicismo” di Gioacchino che mi interessa; e che mi sembra particolarmente significativo della presenza del nocciolo cristiano nella tradizione filosofica europea.
Faccio poi un passo avanti e constato che, come Gioacchino ha esercitato la sua filosofia-teologia principalmente, e forse esclusivamente, come meditazione sulla storia, così Heidegger, dopo la “svolta” del suo pensiero seguita a Essere e tempo (ma già, guardandola restrospettivamente, in quella prima opera) non ha fatto altro che leggere i segni dei tempi.
Si noti, a proposito del leggere i segni dei tempi, che sotto molti aspetti una gran parte della filosofia, almeno dopo Hegel,è riflessione sulla storia, e non più ricerca dei primi principi, delle strutture essenziali dell’essere, eccetera. Lukacs parlò a proposito di Simmel di un “impressionismo sociologico”; ma l’espressione si può applicare, oltre che a Heidegger, a Benjamin, Adorno, Jaspers, Lévinas…
Si può trovare una motivazione analoga in Gioacchino? Questa è una delle domande a cui spero di essere aiutato a rispondere dai colleghi in questo convegno.
Ma anche a prescindere dalle non semplici verifiche testuali, è ragionevole pensare che Gioacchino leghi la propria dottrina delle aetates e degli status al fatto storico di trovarsi in quello che pensa sia l’inizio della terza età.
Una conferma di questa ipotesi credo si debba cercare in un altro aspetto della dottrina dell’abate, che è riconosciuto generalmente dagli interpreti; e cioè che del regno dello spirito a cui saremmo sul punto di arrivare, o a cui si arriverà dopo gli eventi apocalittici profetizzati imminenti, non c’è una vera descrizione; certo si tratta del fatto che non possiamo vedere questi tratti del regno dello spirito se non nella misura in cui esso si avvicina e si realizza; ma forse anche, possiamo pensare, a causa del fatto che la sua essenza consiste nella realizzazione della libertà anche come consapevolezza del ritmo triadico della storia in cui si articola l’avvento del regno di Dio. Certo il regno dello spirito è la realizzazione piena dell’amore cristiano, della pace, della sicurezza e della contemplazione. Ma ciò che, potremmo dire, distingue la perfezione cristiana del terzo stato da quella che pure si è realizzata nei santi delle altre epoche va cercato nella consapevolezza del ritmo della storia, che è anche il ritmo del cosmo e della vita umana, come espressione della stessa vita trinitaria di Dio (si veda un bel passo del Mottu, La manifestation ecc., che traggo da Tagliapietra, p.49 della introd.).
Gioacchino sembra qui anticipare l’amor dei intellectualis di Spinoza e lo spirito assoluto di Hegel: la salvezza consiste nella piena comprensione della storia che la realizza. (** Devi sviluppare: in che senso la “presa d’atto” che siamo nel terzo regno rende più possibile l’amore del prossimo e la pace? O meglio: è forse la stessa presa d’atto della storicità della salvezza che ci rende più amorevoli e meno conflittuali? Forse come in Hd. - assumere la propria mortalità è questo, non assolutizzarsi, “fare spazio” agli altri: Anassimandro...).
Tra i tanti problemi che una simile ipotesi solleva, ne discuterò qui solo due, che mi paiono essenziali.
Anzitutto: come si può esplicitare, documentare, articolare meglio la analogia tra la condizione storica di Gioacchino e la nostra (di Heidegger), che nell’ipotesi sono determinanti per la “scoperta” dell’essere come evento? E: quali che siano i tratti concreti dell’epoca in cui diventa pensabile l’essere come evento, non sarà essenziale che, sia Gioacchino sia Heidegger, la pensino in termini apocalittici, cioè come epoca “finale”?
Non c’è dubbio che presso Gioacchino il tratto apocalittico della terza età è pensato anche, benché non soltanto, nel senso tragico che il termine ha sempre avuto nel linguaggio comune - l’apokalypsis-rivelazione accade alla fine di un periodo di violenza, di guerre e stragi sanguinose.
La figura del Saladino degli scritti di Gioacchino non potrebbe essere accostata a quella del presidente Bush, o a quella di Bin Laden - mutatis tutti i mutandis? Il termine crociata che è ridiventato di moda nella retorica giornalistica e politica è certo solo un indizio vago ed esteriore. Voglio dire però che, se ci mettiamo sul piano (più profetico-gioachimita che filosofico-heideggeriano, lo riconosco), le possibili analogie si trovano in pericolosa abbondanza.
Sulla base di esse, non sarebbe difficile annettere Gioacchino al gruppo di coloro che, contro allo spirito di crociata che sembra imporsi un po’ dovunque - certo sia in Bin Laden sia in Bush - contrappongono la politica della parola e del dialogo; per questo rimando alle pagine della Expositio citate dettagliatamente da Daniel in un articolo del 1969 riprodotto ora nel II volume di West, p.310 e passim.

Ma naturalmente il problema più fondamentale per chi voglia riprendere - sia pure con tutta libertà interpretativa - Gioacchino , rivendicandone l’eredità filosofico-cristiana, è quello del millenarismo. Bisogna cioè domandarsi se davvero la consapevolezza del ritmo triadico della storia, l’aspettativa di un terzo regno che comincerebbe a realizzarsi sulla terra (con tutte le implicazioni anche “politiche” che questa aspettativa comporta; pensa a Bloch, a Muenzer, a Fra Dolcino) sia inscindibile dalla pretesa di vivere alla fine dei tempi e nel momento del loro compimento non solo cronologico ma anche, per dir così, assiologico. Si sa che il millenarismo è sempre stato sospetto ad ogni spirito liberale perché la sua pretesa di perfezione realizzata sembra comportare la negazione di ogni libertà e di ogni apertura a ulteriori cambiamenti.
In una Unione Sovietica finalmente “rivoluzionata”, chi propone ulteriori cambiamenti o si sente ancora “alienato”, è un pazzo (da manicomio) o un agente del nemico (da gulag). Eccetera. Si può, insomma, fare una filosofia della storia che non sia anche una filosofia della, e dalla, fine della storia?
Ha ragione Andrea Tagliapietra quando scrive, nella citata introduzione, che “ Il futuro, più che essere ciò che sopraggiunge fuori dell’orizzonte della storia, è ciò che CONTRADDICE la storia presente. Il fine della storia non si limita a totalizzarla, ma diviene il criterio di giudizio che opera dal suo interno” (p.43).
Anche leggendo Gioacchino, come leggendo lo Heidegger teorico della fine della metafisica, non bisogna tanto cercarvi i segni della fine imminente, quanto l’operare del fine come criterio di giudizio.
L’atteggiamento di chi cerca i segni della fine, e pretende di rifiutare la dottrina perché questa fine, di fatto, non si dà, è come quello di chi confonde profezia e divinazione magica, il profeta con la chiromante e l’astrologo. Nelle “profezie” di Gioacchino ci sono certo anche molti elementi di questo tipo, e anzi forse tanti da oscurare il senso che, almeno per noi, è più decisivo del suo pensiero, la nozione dei tre stati e quello che, in breve, possiamo chiamare il suo storicismo. La questione del millenarismo comporta anche questo aspetto: si può separare Gioacchino “storicista” dal veggente che annuncia questo o quell’evento specifico in un tempo determinato? E se dovessimo essergli fedeli anche e soprattutto nel riconoscere che, essendo entrati nel regno dello spirito, almeno avendone riconosciuti i prodromi, possiamo non prendere più alla lettera anche le sue profezie?
San Giovanni in Fiore, 25 settembre 2004
Abbazia Florense - florense.it
Gioacchino da Fiore Le Memorie di Luca Campano
Centro Internazionale di Studi Gioachimiti
Gioacchino da Fiore - Wikipedia
Gioacchino da Fiore nell'Enciclopedia Treccani
Gioacchino da Fiore | Stupor Mundi
Web Master - Content - SEO - Francesco Saverio Alessio - all rights reserved © copyright 2003/2023